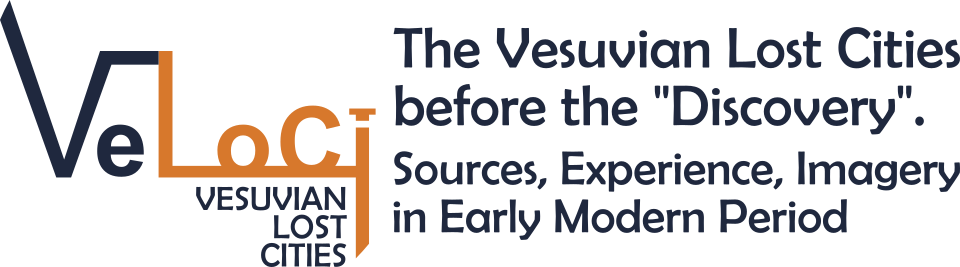The Vesuvian Lost Cities before the “Discovery”: Sources, Experience, Imagery in the Early Modern Period
Osservazioni a margine del Panel presentato all’RSA Boston 2025 di disseminazione del progetto VeLoCi
Il 20 marzo 2025 si è svolto presso il 71° Renaissance Society of America Annual Meeting, tenutosi a Boston MA (Usa), il Panel The Vesuvian Lost Cities before the “Discovery”: Sources, Experience, Imagery in the Early Modern Period, una nuova attività di disseminazione del progetto VeLoCi. Il Panel è stato curato da Giulia Ceriani Sebregondi e Francesca Mattei, e presieduto da Ilaria Andreoli (INHA).
Tale iniziativa ha inteso condividere i risultati di oltre un anno di lavoro del progetto di ricerca, che si concentra sull’analisi delle città vesuviane sepolte di Pompei, Ercolano, Oplonti e Stabia, prima dell’inizio degli scavi ufficiali di metà Settecento, con particolare attenzione al periodo tra XV e XVII secolo. A tal fine è stato anche distribuito, durante la mattinata e i giorni di convegno, del materiale informativo sul Panel e sul Progetto, appositamente concepito ed elaborato dai membri del Research Team del progetto.
Secondo la lettura tradizionale, la vita successiva all’eruzione del 79 dC delle città vesuviane è iniziata con l'avvio degli scavi ufficiali di Ercolano e Pompei, rispettivamente nel 1738 e nel 1748. Tuttavia, alcuni studi hanno dimostrato che l’area vesuviana è stata indagata nei secoli precedenti da un punto di vista umanistico e proto-archeologico. Le fonti letterarie testimoniano che parti degli antichi monumenti di Pompei erano visibili in epoca moderna e tra il 1592 e il 1600 furono rinvenuti alcuni dipinti, iscrizioni ed elementi architettonici durante la costruzione del Canale di Sarno sotto la direzione dell'architetto Domenico Fontana, solo per citare l’esempio più noto.
In che misura, dunque, le città vesuviane, erano (s)conosciute prima degli scavi archeologici del XVIII secolo? Ponendo la storia dei disastri in dialogo con la storia della scoperta del passato, il progetto VeLoCi, finanziato dal Ministero italiano dell'Università e della Ricerca, si propone di innovare narrativamente la storia delle città vesuviane sepolte attraverso un'indagine sistematica delle fonti iconografiche, testuali e materiali precedenti agli scavi archeologici.
Il Panel, quindi, dopo la presentazione generale del tema da parte di Ilaria Andreoli e una breve introduzione al progetto VeLoCi di Giulia Ceriani Sebregondi, ha raccolto quattro contributi dei membri del gruppo di ricerca di VeLoCi, con lo scopo di condividere i risultati intermedi di questo progetto biennale. Esaminando diverse tipologie di fonti, ogni intervento è stato dedicato a un tema indagato nella ricerca: 1. l'analisi delle testimonianze proto-archeologiche per la conoscenza del territorio; 2. il ruolo delle fonti testuali per la creazione dell'immaginario; 3. lo studio delle fonti iconografiche e delle mappe per ricostruire il paesaggio prima degli scavi; 4. la raccolta e l'esposizione delle testimonianze materiali antiche per la memoria pubblica.
La prima relazione, di Giulia Ceriani Sebregondi, intitolata When Were the Vesuvian Lost Cities Discovered? Traces and Evidence from the Early Modern Period, è partita dalla domanda alla base del progetto di ricerca: Quando sono state scoperte le città vesuviane sepolte? Mettendo in discussione la narrazione secondo cui sarebbero rimaste sepolte sotto la cenere e il materiale vulcanico, completamente sigillate dall'intervento umano, nascoste per più di 16 secoli, ha indagato le testimonianze archivistiche e materiali della prima età moderna che testimoniano la visibilità e il rinvenimento di alcune delle rovine di Pompei, Ercolano, Oplontis e Stabiae prima della loro “scoperta” e ci permettono di ricostruire almeno in parte il paesaggio di quest'area durante la prima età moderna. Quanto e cosa avevano effettivamente “scoperto” gli umanisti, gli architetti e gli antiquari campani? Perché le loro testimonianze sono rimaste ai margini del dibattito sullo studio dell'Antico e della straordinariamente intensa impresa collettiva della sua conoscenza? Attraverso il caso di studio dell’area di Castellammare di Stabia, il contributo ha inteso esemplificare una prima raccolta delle informazioni frammentarie e molto disperse su questo tema e verificare questa ipotesi, avanzando alcune prime risposte.
La seconda relazione, presentata da Francesca Mattei, intitolata Unknown Celebrity. The Topography of Vesuvian Area in the Early Modern Period, ha focalizzato l’attenzione sul fascino antiquario per il sottosuolo campano durante la prima età moderna, ispirato da scavi intenzionali e ritrovamenti fortuiti, legato agli studi sul paesaggio ipogeo e le ricerche sul sottosuolo, provocando una fusione creativa tra immaginario artistico e letterario e conoscenza empirica. Concentrandosi sul monumento naturale costituito dall’area vesuviana, l’intervento ha inteso mettere metodologicamente alla prova il dialogo tra studi sui disastri, discussioni di storia naturale e tradizione antiquaria nella prima età moderna, sfruttando l'ambivalenza di questo caso studio. Da un lato, infatti, la storia dell'area vesuviana è stata trasmessa fin dall'antichità a causa dei famosi terremoti ed eruzioni vulcaniche che l'hanno colpita. Dall'altro, il suo territorio è diventato misterioso a causa della perdita di ingenti testimonianze materiali, svanite dopo i disastri. Attraverso un'analisi comparata di fonti antiquarie, letterarie e scientifiche, come Flavio Biondo, Ambrogio Leone, Pirro Ligorio, Colanello Pacca de' Medici, Gaspare Paragallo, Francesca Mattei ha ricostruito il dialogo intorno alla topografia dell'area, interrogandosi sugli strumenti per indagare la geografia del territorio all'incrocio tra ricerca in loco e immaginario.
Il terzo intervento, di Milena Viceconte, intitolato Recovering the Vesuvian Lost Cities through engraved sources: the 17th-century Landscape views by Nicolas Perrey, ha esaminato la presenza delle città vesuviane nella cartografia napoletana del XVII secolo. In particolare, ha preso in considerazione la produzione grafica dell'incisore francese Nicolas Perrey (1596-1661), al quale si devono alcune vedute paesaggistiche dell'eruzione del 1631. Si tratta di ‘vere raffigurazioni’ pubblicate per illustrare i trattati di eruditi dell'epoca, come Braccini, Giuliani e Mascolo, e concepite per mostrare il paesaggio vesuviano prima dell'eruzione, con il doppio cono coperto da una rigogliosa vegetazione, e quindi la sua trasformazione dopo la catastrofe. In queste immagini, che hanno contribuito alla fortuna del topos iconografico del Vesuvio, i siti cittadini oggetto del progetto di ricerca VeLoCi sono chiaramente indicati nella loro forma latina (Herculanum, Pompeij) accanto ai nuovi insediamenti sviluppatisi successivamente, come Torre del Greco e Torre Annunziata, drammaticamente devastati dalle colate laviche emerse dal vulcano nel 1631. Confrontando queste rappresentazioni con esempi della tradizione cartografica napoletana, si è sottolineata la persistenza di questi toponimi e la loro importanza per identificare con precisione dove si trovavano le antiche città sepolte, più di un secolo prima degli scavi ufficiali.
Il quarto e ultimo intervento, di Giorgia Aureli, intitolato Private Discoveries for Public Memory: Antiquities on Display in Early Modern Rome and Naples, è tornato ad affrontare il tema delle attività proto-archeologiche che portarono alla luce sporadiche testimonianze materiali prima degli scavi ufficiali che scoprirono ampie porzioni delle antiche città vesuviane. Alcune di queste scoperte, invece di essere confinate in collezioni private accessibili solo a pochi eruditi, furono esposte pubblicamente in mostre appositamente costruite, consentendo un accesso e un'ammirazione più ampi, come il monumento del XVI secolo dei Collimozzi a Resina, l’attuale Ercolano. La relazione ha preso in esame una selezione di casi di studio dell'area vesuviana e, con un approccio comparativo, ha esplorato ulteriori casi di esposizione pubblica di antichità provenienti da ritrovamenti privati a Roma e a Napoli, centri chiave della cultura antiquaria a partire dalla fine del XV secolo. É stato dunque ricostruito il contesto di queste iniziative, evidenziandone le caratteristiche e le finalità, analizzando altresì le composizioni architettoniche degli allestimenti. Indagando l'interazione tra architettura e scultura, nonché il rapporto tra le antichità e gli spazi urbani, l’intervento ha illustrato come queste soluzioni abbiano contribuito a plasmare l'identità civica dei luoghi, facendo luce sugli aspetti pubblici delle intenzioni private dei collezionisti e sul loro ruolo nel rendere le antichità accessibili a un pubblico più vasto, nella prima età moderna.
Il Panel ha visto un’ampia partecipazione di pubblico, tra cui Caroline Bruzelius, Jasmine Cloud, Ludovica Galeazzo, Simone Fatuzzo, Matteo Lazzari, Sarah W. Lynch, Roberta Martinis, Elizabeth Merrill, Morgan NG, Silvia Tita. Nel corso del dibattito finale sono state poste domande sulla genesi del progetto e sulla questione chiave del perché si sia affermata la narrazione della ‘scoperta’ settecentesca, per poi focalizzarsi sul Database VeLoCi, volto a interconnettere e gestire dati documentari, materiali e iconografici mediante le nuove tecnologie, strumento che è stato illustrato tramite una breve dimostrazione da parte del Research Team.
Il Panel ha rappresentato una importante Milestone del progetto VeLoCi, che proseguirà le attività di disseminazione dei risultati in occasione della Final Conference "Lost Cities in a Global Perspective: Sources, Experience, Imagery in the Early Modern Period (XV-XVIII century)", che si terrà a Caserta nella sede del Rettorato dal 16 al 17 ottobre 2025.
Tutti gli aggiornamenti sul progetto VeLoCi sono pubblicati alla sezione “notizie ed eventi” e sulle nostre pagine social Facebook e Instagram.
Giorgia Aureli, Giulia Ceriani Sebregondi, Francesca Mattei, Milena Viceconte